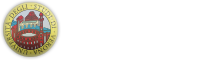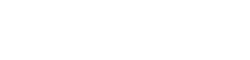- Autori:
-
Residori, Sonia
- Titolo:
-
«Nessuno è rimasto ozioso»: campi di concentramento e prigionieri austro-ungarici in Italia durante la Grande Guerra (1915-1918).
- Anno:
-
2017
- Tipologia prodotto:
-
Doctoral Thesis
- Lingua:
-
Italiano
- Parole chiave:
-
campi di prigionia in Italia, Prima guerra mondiale, lavoro forzato, malattie epidemiche, convenzione di Ginevra,
- Abstract (italiano):
- Nel corso del primo conflitto mondiale, il numero crescente dei prigionieri di guerra obbligò i Paesi belligeranti a passare dai depositi allestiti in strutture già esistenti, come caserme e fortezze, alla costruzione di campi di concentramento secondo criteri più moderni, edificando agglomerati di baracche in legno o in pie-tra. In un’ottica di gestione economica degli uomini, i prigionieri di guerra costituirono ben presto una risorsa fondamentale per lo sforzo bellico e il lavoro fu reso divenne obbligatorio per tutti i prigionieri. In Italia l’avvio avvenne con cautela per il timore di ledere la manodopera locale, ma ben presto si sviluppò un vero e proprio sistema organizzato di lavoro forzato che modellò la struttura dell’internamento militare e in breve agricoltura e indu-stria, settore privato e quello pubblico si contesero l’assegnazione delle centurie di prigionieri. Dopo la sconfitta di Caporetto, le inevitabili ripercus¬sioni tolsero i prigionieri dal lavoro per l’economia del Paese, per mandarli come manodopera in zona di guerra, dove divennero vere e proprie truppe di seconda linea al fronte. Al pari degli altri stati belligeranti, il governo italiano decise di perseguire la politica della divisione delle nazionalità con la creazione di veri e propri campi di concentra-mento dove, attraverso la propaganda, si formarono reparti di prigionieri di guerra appartenenti alle nazionalità “oppresse” da affiancare, a vario titolo (legioni ar-mate o squadre di avvicinamento o servizio di infiltrazione), all’esercito italiano. Dopo l’armistizio del 4 novembre 1918, l’afflusso massiccio di prigionieri austro-ungarici, mal ridotti e affamati, mise in grande difficoltà la struttura concentrazio-naria italiana, evidenziando le incapacità di taluni singoli, prontamente sostituiti, e i contrasti tra l’autorità politica e quella militare. I prigionieri scontarono la preca-ria situazione con fame, freddo e malattie epidemiche (tifo petecchiale e malaria), ma anche la volontà punitiva dei vincitori. Lo Stato italiano, infatti, mentre asse-gnava razioni alimentari di rappresaglia a guerra terminata, negò sempre ostina-tamente il permesso di visitare le proprie strutture ai rappresentanti della Croce rossa non solo ungherese e austriaca, ma anche quella internazionale di Ginevra.
- Id prodotto:
-
96502
- Handle IRIS:
-
11562/957759
- ultima modifica:
-
3 novembre 2022
- Citazione bibliografica:
-
Residori, Sonia,
«Nessuno è rimasto ozioso»: campi di concentramento e prigionieri austro-ungarici in Italia durante la Grande Guerra (1915-1918).
Consulta la scheda completa presente nel
repository istituzionale della Ricerca di Ateneo